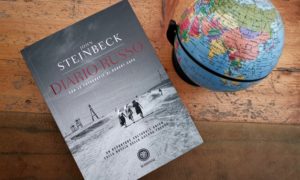È la Bulgaria ad aggiudicarsi il premio per il miglior lungometraggio al Trieste Film Festival 2020: s’intitola Bashtata (The father – Il padre) ed è diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov, noti al pubblico in Bulgaria e all’estero nel 2014 con Lesson, seguito due anni dopo dal film Glory. Il loro terzo film, però, è molto diverso dai precedenti e, dopo aver vinto il Crystal Globe per il Grand Prix alla 54a edizione del festival cinematografico di Karlovy Vary, ha convinto anche il pubblico del festival dedicato al cinema dell’Europa centro orientale che sa 31 anni si svolge a Trieste.
Un successo quasi annunciato visto i lunghissimi applausi che il pubblico ha tributato, al termine della proiezione, all’attore protagonista di The Father, Ivan Barnev, uno dei volti più noti del cinema bulgaro, presente in sala e salito sul palco a raccontare curiosità e retroscena del film che lo ha visto protagonista insieme a Ivan Savov, un altro attore molto conosciuto in Bulgaria.
Rispetto alle edizioni del passato, mi è sembrato che nell’edizione di quest’anno il nuovo cinema dei Paesi di quella che un tempo si definiva l’oltre cortina di ferro si sia concentrato sul racconto del disagio dell’uomo contemporaneo più che sulla memoria della guerra, in particolare dell’ex Jugoslavia.
Dei lungometraggi in concorso che sono riuscita a vedere (9 su 11), soltanto il kosovaro Zana – stupenda opera prima intrisa di commoventi elementi autobiografici di Antoneta Kastrati – ritorna esplicitamente su quelle ferite. Tutti gli altri si concentrano su tematiche complesse della contemporaneità, dai conflitti privati e familiari, a quelli sociali.
In questo post vi parlo delle quattro pellicole che mi sono piaciute di più dei 9 su 11 lungometraggi in concorso che sono riuscita a vedere.
BASHTATA – THE FATHER
di Kristina Grozeva e Petar Valchanov
BULGARIA
In un atipico road-movie, The Father racconta del viaggio che i due protagonisti, il padre Vassil e il figlio Pavel, si ritrovano loro malgrado a fare insieme dopo che il padre, per far fronte alla perdita della moglie Valentina appena defunta, cerca di connettersi con lei tramite l’aiuto di un sensitivo, nonostante il disaccordo del figlio.
L’elaborazione di un lutto attraverso il viaggio assurdo e sgangherato tra i villaggi della campagna bulgara, tra sensi di colpa e legami da riallacciare, condurranno i due protagonisti a vivere situazioni al limite del paradosso, in cui gli episodi divertenti si alternano a quelli malinconici, in un sapiente dosaggio che spesso caratterizza il cinema balcanico.
Il via alle disavventure nasce dal fatto che una vicina sostiene che Valentina continui a tentare di chiamarla al cellulare. Un episodio bizzarro che uno dei due registi ha preso da un’esperienza personale: dopo la morte della madre qualcuno sosteneva la presenza di telefonate di questo tipo. La vicenda fornisce il pretesto ai registi di raccontare un aspetto poco esplorato di alcune zone della Bulgaria, ovvero la presenza e il poter assunto da alcuni leader spirituali che hanno soppiantato quelli comunisti e hanno avuto grande successo, soprattutto nella popolazione anziana.
Ma il film si concentra anche sulla relazione con i propri genitori anziani: molti di noi si riconoscerebbero in quel figlio alle prese con il più cocciuto dei padri che, anche mettendo a repentaglio la sua salute e la sua sicurezza, vuole mettere in atto le sue convinzioni. Nonostante il suo comportamento difficile e la relazione tesa tra i due, Pavel, alternando risentimento e affetto verso il padre, continua a prendersi cura di lui, rischiando di mettere a repentaglio la sua vita privata e il suo lavoro, inanellando una serie di bugie che, seppur a fin di bene, rischiano di fargli perdere il controllo della sua vita.
Al tema dei legami familiari e del senso di perdita, centrali nella narrazione, aggiungono un tocco affascinante particolari divertenti e soltanto apparentemente banali, come il riferimento alla madre di Pavel, famosa attrice di film partigiani di epoca comunista o quello alla marmellata di mele cotogne che la moglie di Pavel desidera tanto a causa delle voglie dovute alla gravidanza. Sono tutti dettagli che, oltre ad arricchire una sceneggiatura che coglie nel segno, sono parte integrante del film e della poetica bulgara.


MONSTRI. – MOSTRI. di Marius Olteanu
ROMANIA
Tra i film del Trieste Film Festival c’è sempre almeno un film che proviene dalla Romania che amo più di altri e che mi sembra distinguersi. Monstri. è stato quel film per l’edizione 2020. E mi sono chiesta a più riprese se non avrebbe meritato di vincere. Sicuramente più di nicchia rispetto al bulgaro Bashtata, così cupo, introspettivo e pieno di quella densa malinconia di cui spesso è fatto il cinema rumeno.
Olteanu si cimenta con un tema – quello di un matrimonio in crisi – a rischio déjà-vu e riesce, invece, a realizzare un’opera originale, sia per contenuto sia per lo stile, raccontando, con delicatezza e intensità, una storia d’amore, di crisi e di compromessi ambientata a Bucarest in 24 ore. Il regista in sala ha spiegato la volontà di analisi della società rumena anche attraverso le case e gli spazi in cui i protagonisti del suo film.
Presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2019 e premiato come Miglior Opera Prima al Festival di Cluj, il film si compone di tre atti chiaramente distinti: il primo racconta la storia dal punto di vista di Dana, il secondo da quello di Arthur, il terzo vede la coppia insieme. I primi due atti, in formato verticale, si svolgono durante la medesima notte, il terzo, in grande schermo, il giorno successivo. È un film fatto soprattutto di pesanti silenzi, di lunghi sguardi, di movimenti soppesati, di segreti che non sono più tali ma a cui non si riesce a reagire, di mostri interiori. Nel dubbio che questo magnifico film possa essere distribuito in Italia, vi evito spoiler.

NECH JE SVETLO (LET THERE BE LIGHT – CHE SIA FATTA LUCE)
di Marko Škop
SLOVACCHIA
Una storia familiare intorno al tema del bullismo e dei gruppi paramilitari slovacchi: il film di Marko Škop, che ha vinto il Premio InCe Iniziativa Centro Europea “per l’attenzione rivolta alla formazione dei più giovani ponendo educazione e cultura come unica risposta contro intolleranza e razzismo”, è una prova decisamente convincente che racconta la Slovacchia contemporanea, affrontando in modo esplicito i temi dell’emigrazione, del razzismo, dell’omofobia e del bullismo.
Ambientato nel nord della Slovacchia, il film racconta la storia di un padre, un uomo qualunque emigrato in Germania per lavoro, che torna a casa per le festività natalizie e si trova ad affrontare il fatto che il figlio maggiore sia entrato a far parte di un gruppo paramilitare che ha causato il suicidio di un compagno di classe, oggetto di bullismo perché ritenuto omossessuale.
Anche questa una storia di padri e di figli, come il film bulgaro vincitore, diversa per temi e per punti di vista, non più di tanto per le incomprensioni e le difficoltà di rapporti che da sempre sono presenti nelle diverse generazioni. Anche in questo film, inoltre, la religione – intesa come credenze e rituali – è un elemento essenziale. Non c’è musica: il regista ha deciso di realizzare una pellicola secca e asciutta, evitando così che la musica costituisse una distrazione o una sovrapposizione agli elementi importanti del film.
Marko Škop non risparmia critiche, definendo “uno stato fantoccio” la Slovacchia ai tempi del nazismo, quando il presidente era un prete cattolico e la religione da sempre associata ai temi del nazionalismo. “Ci sono ancora sentimenti verso questo tipo di stato oggi in Slovacchia –ha dichiarato il regista in sala – speriamo soltanto non siano la maggioranza”.



ZANA
di Antoneta Kastrati
KOSOVO
Mentre scorrono i titoli di coda si scopre che il film ha una dedica: alla madre e alla sorella della regista e della direttrice della fotografia, sorella della regista, uccise durante la guerra del Kosovo. È la stessa Antoneta Kastrati a raccontare la sua storia al pubblico in sala: “Ci ho messo 20 anni per fare questo film e per affrontare il mio passato, faccio sogni e incubi da sempre, proprio come quelli della protagonista del mio film. Quando sono diventata madre la mia più grande paura è diventata quella di perdere mio figlio. Così nel film ho deciso di unire gli elementi autobiografici al punto di vista di una madre che perde il figlio e la vita da quel momento per lei è finita. Mi interessava raccontare la storia da un punto di vista femminile e non soltanto il trauma della guerra”.
Semplice e diretto, con una magistrale fotografia (la commovente scena finale ha qualcosa di preraffaeliano), Zana, anteprima europea al Trieste Film Festival, è un film intenso, di quelli che lascia con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, di quelli in cui entri immediatamente in empatia con la protagonista, immersa nella società ancora molto conservatrice e patriarcale kosovara, dove le donne devono fare figli e non hanno molta altra voce in capitolo e dove la magia nera e i guaritori hanno ancora una rilevanza per gli abitanti che si rifugiano nell’aspetto mistico nella speranza di avere risposte.
Antoneta Kastrati e la sorella Sevdije hanno un’importanza fondamentale anche perché hanno fatto da apripista a un gruppetto di cineaste kosovare, in cui l’industria cinematografica è agli esordi e ancora di più quella femminile. Antoneta Kastrati si è trasferita dieci anni fa negli Stati Uniti ma torna spesso in Kosovo e questo film è stato girato nel suo villaggio d’origine, dove gli abitanti conoscono pochissimo il cinema: “Molti di loro ci hanno aiutato – ha detto la regista – e tra le comparse ci sono persone che hanno effettivamente perso i loro cari durante la guerra”.


GLI ALTRI PREMI
All’Ungheria il secondo riconoscimento importante: il Miglior Documentario in concorso è A létézés eufóráia (L’euforia dell’esistenza) di Réka Szabó: la direttrice di una delle più importanti compagnie di danza magiare ha convinto Éva Fahidi, 90enne e unica della sua famiglia ad aver fatto ritorno da Auschwitz, a creare una performance teatrale sulla sua vita. Il documentario ha vinto anche il premio dell’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa “perché riesce a farci apprezzare, in quest’epoca di disillusione e assenza di prospettive, la forza dell’esistere e il presente come opportunità di riscatto attraverso la belezza, la tenerezza e persino a mostrare il valore della fragilità. Perché incarna nell’incontro tra una donna anziana e una giovane danzatrice professionista, la bellezza del contatto con l’altro, contro l’intento dei carnefici nazisti di annichilire il corpo e de-umanizzare la persona. Per l’originalità con cui affronta il tema dell’elaborazione della memoria e ci racconta la storia di chi è stata vittima di un sistema di morte trasformandola in protagonista della vita per mezzo dell’arte”.
Al bielorusso Lake of happiness di Aliaksei Paluyan è andato invece il Premio Fondazione Osiride Brovedani per il Miglior Cortometraggio sui 14 in gara. Si tratta di un cortometraggio di mezz’ora, quello con la maggior durata tra quelli in gara.
Per quanto riguarda i riconoscimenti conferiti dalle giurie, il Premio Corso Salani è andato a Micol Roubini per il suo La strada per le montagne, “un viaggio alla ricerca di un luogo perduto della storia familiare che si rivela come il castello di Kafka. La regista si spinge sempre in profondità di una selva di storie intime e personaggi picareschi con l’implacabile determinazione di chi non abbandona la posizione”.